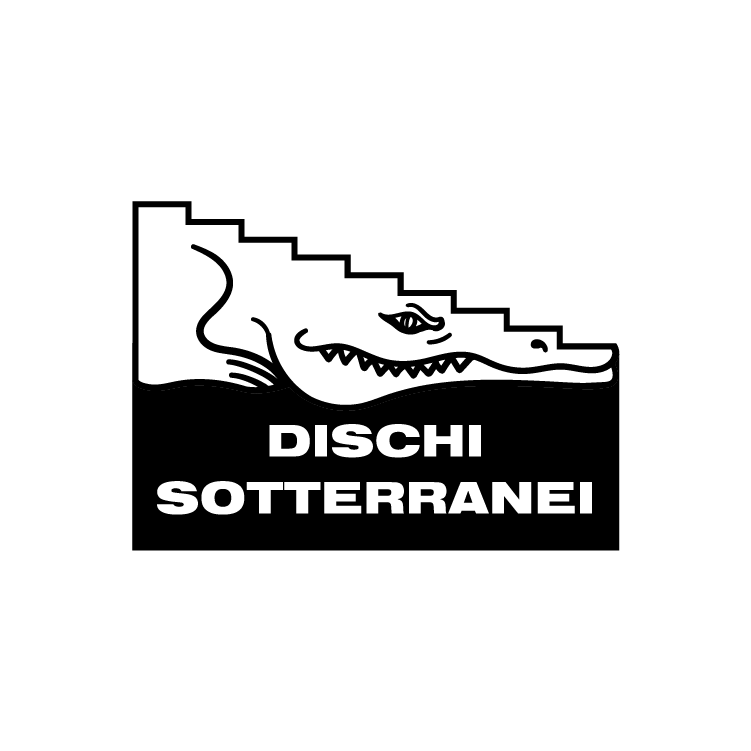Mi sovviene di mattina, quando la panna dei concetti riaffiora dopo la notte, il pensiero sgangherato e disordinato che esista una metafisica dell’indipendenza. Vale a dire una teoria posta a fondamento di un’idea ancora più grande, una sorta di materia prima sulla quale costituire un elemento ben più complesso. Il filo di lana prima del maglione, il chicco di mais prima della tortilla, un sistema di infinitesimali caratteri universali che riguardano l’indipendenza. Qualsiasi cosa voglia dire questa parola.
Ho trascorso l’adolescenza sulle scalette ai bordi del piazzale della scuola Panzini, via Byron, Corticella, rione nord di Bologna. La periferia ha un portentoso fascino su di me, anche se il punto d’osservazione è una scaletta. Un ascendente avvalorato dal fatto che quel gigantesco piazzale è stato il ritrovo di una screziata comunità di skater, che all’epoca popolavano i cementi della vicina Castel Maggiore, o dell’Elbo di via Romita, o della Montagnola, nel centro di Bologna. Corticella è un agglomerato dalla fisionomia irrisolta, è un’area imprecisata tagliata a metà dall’omonima via, attorno alla quale sono incastonate l’ex campo di concentramento nazista delle Caserme Rosse, il dismesso pastificio Corticella, il teatro Centofiori e una piccola comunità nordafricana che pitta le notti del bar Carosella 2. La denominazione Corticella discende da curtis, ovverosia quell’area imprecisata e irrisolta che nell’antichità ha dato origine all’economia curtense basata sull’autoconsumo dei suoi stessi beni. E relazioni. Corticella, Curdgèla, curtis. Di quella comunità di skater mi affascinava la partecipazione scriteriata e senza alcun senso: libera, imparziale, un’adesione fine a se stessa, trasgressiva, colorata e chiassosa. Quel genere di cose che non puoi spiegare ai genitori, non perché non capirebbero, ma perché talmente sconclusionate da non trovare le parole giuste. Buona parte degli skater aveva anche una band: tipo che Frankie cantava nei Milkshaker Corporation e oggi è il tastierista de Lo Stato Sociale, tipo che Santo cantava nei Seventy Ace, band intermedia fra i Fartbash e gli Hilldale, e oggi è il mio tatuatore e il mio fotografo preferito.
 Ho ancora un grande timore reverenziale nei suoi confronti. Gli ho chiesto di raccontarmi una storia per questo articolo:
Ho ancora un grande timore reverenziale nei suoi confronti. Gli ho chiesto di raccontarmi una storia per questo articolo:
“Mio nonno era tutto per me, mi ha fatto da padre e quando morì andai giù, ma tanto giù. Mio padre se ne accorse e da bravo matematico fece i suoi calcoli. Stavo da mattina a sera con le cuffie nelle orecchie, vivevo -e vivo- per la musica. Un bel giorno arrivò con un ampli 15W Ibanez e una chitarra elettrica Yamaha. La mia storia parte da qui, dalle giornate passate a imparare uno strumento cattivo, cattivo se uno lo vuole cattivo, perché la chitarra in realtà è roba da innamorati. Io odiavo tutti, il mio suono doveva odiare tutti. Suonavo, suonavo, suonavo, ascoltavo, ascoltavo, ascoltavo: e poi tramite lo skate mi sono ritrovato con Dedde, Mone e Santi.
 Da lì iniziammo a suonare, roba nostra perché -che cazzo- le cover sono cose di altri, cose intime: scoperesti mai la ragazza del tuo migliore amico? Se sì, ok, farai parte di una cover band a vita. Andavamo ai concerti, quelli con le lire: roba da matti pensare che l’ingresso di un concerto costasse 5000 lire. Iniziammo a chiedere di suonare ovunque, perché non era giusto che le canzoni restassero dentro quattro mura insonorizzate. Non era giusto per me, né per mio padre, men che meno per mio nonno. Come ben sai, se mi pongo un obiettivo, lo raggiungo nel bene o nel male. E così fu. Riuscii ad entrare nel giro della HCBO. Non sto a dirti quanto fossi gasato e orgoglioso nel vedere il nome Fartbash nel gruppo HCBO. Una scena bolognese che non esisterà mai più. Sì, mi sentivo parte di una scena che ha fatto la storia, ma non me ne frega un cazzo se nessuno ci ricorda, suonavo suono e suonerò per tenermi vivo. Come un dottore che scopre la cura del cancro, come un astronomo che scopre costellazioni nuove, io avevo scoperto me stesso. Questo ha significato per me quel periodo. Starei a parlarne con te per ore, ma mi fermo qui perché sono andato anche oltre”.
Da lì iniziammo a suonare, roba nostra perché -che cazzo- le cover sono cose di altri, cose intime: scoperesti mai la ragazza del tuo migliore amico? Se sì, ok, farai parte di una cover band a vita. Andavamo ai concerti, quelli con le lire: roba da matti pensare che l’ingresso di un concerto costasse 5000 lire. Iniziammo a chiedere di suonare ovunque, perché non era giusto che le canzoni restassero dentro quattro mura insonorizzate. Non era giusto per me, né per mio padre, men che meno per mio nonno. Come ben sai, se mi pongo un obiettivo, lo raggiungo nel bene o nel male. E così fu. Riuscii ad entrare nel giro della HCBO. Non sto a dirti quanto fossi gasato e orgoglioso nel vedere il nome Fartbash nel gruppo HCBO. Una scena bolognese che non esisterà mai più. Sì, mi sentivo parte di una scena che ha fatto la storia, ma non me ne frega un cazzo se nessuno ci ricorda, suonavo suono e suonerò per tenermi vivo. Come un dottore che scopre la cura del cancro, come un astronomo che scopre costellazioni nuove, io avevo scoperto me stesso. Questo ha significato per me quel periodo. Starei a parlarne con te per ore, ma mi fermo qui perché sono andato anche oltre”.
Stare ai margini mi ha dato la possibilità di farmi sedurre con lentezza, di comprendere le movenze, la parlantina, i gusti musicali, un certo modo di suonare e poi di inserirmi in punta di piedi in quella società scompigliata e anarchica, senza impicciare e senza volerla plagiare. Sono caduto dallo skate e ho lasciato che fossero gli altri a pattinare, poi ho iniziato a suonare coi miei migliori amici e ho lasciato che fosse l’aura di quell’associazionismo insensato a fare il resto. Senza logica, regole pre-stabilite. Sapevo di essere sul loro stesso palcoscenico, certamente sulle scalette ai bordi di un piazzale, più a margine, ma nello stesso teatro.
 Sapevo che ero dalla parte dei non-giocatori, di chi non vuole vincere o perdere, ma di chi vuole giocare per il solo gusto di farlo. L’indipendenza dà la dimensione di ciò che è importante, la totale libertà di non gareggiare. Questa è la mia origine.
Sapevo che ero dalla parte dei non-giocatori, di chi non vuole vincere o perdere, ma di chi vuole giocare per il solo gusto di farlo. L’indipendenza dà la dimensione di ciò che è importante, la totale libertà di non gareggiare. Questa è la mia origine.
Mi sovviene di mattina, quando la panna dei concetti riaffiora dopo la notte, il pensiero di una metafisica dell’indipendenza. Che altro non è che il gran chiasso di tavole da skate sul piazzale di Corticella.
Che altro non è che un movimento teatrale.
Chi entra in scena poi esce.
E lascia spazio a un altro
non senza aver lasciato un seme su questa terra:
- Discografia completa di Farbash, Seventy Ace e Hilldale: shorturl.at/abntC
- ED live al Centofiori: shorturl.at/knrzS
- Madball live al Centofiori: shorturl.at/rtRY7
Buona.
Giacomo Gelati, Altre di B